Presentato stamani il nuovo bando del Premio ‘Terra d’Agavi’, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Terenziano Di Stefano e del presidente del Rotary club di Gela, club service organizzatore. Il premio quest’anno ee giunto alla sua 42ª edizione.
Alle due storiche sezioni relative alla prosa intitolata ad Alfonso Parisi ed alla poesia intitolata al Federico Hoefer, quest’anno si aggiunge una terza sezione con indirizzo di fiabe e favole per bambini. Presidente delle commissioni sarà la dott.ssa Rosalba Panvini, già Soprintendente dei beni culturali di Caltanissetta, Catania e Siracusa.
Delegato del premio Terra d’Agavi 2025 è stato designato il socio Avv. Valentino Granvillano. Componenti delle sottocommissioni un parterre di docenti, dirigenti, soci rotariani e quest’anno per la prima volta l’inserimento anche di una delegazione dell’Interact con il suo Presidente Elias D’Aleo, relativamente alla neo terza sezione destinata a favole e fiabe per bambini.
Nello specifico i componenti saranno: Sez. A: Dirigente Corrado Ferro e i proff Marianna De Fusco, Maria Grazia Falconeri, Antonella Aquino, Laura Cannilla, Olimpia Messina, Paola Greco, Salvo Rita, l’ Arch. Tatiana Valenti e il giornalista Domanico Russello.
Sez. B: Elia Nobile, Andrea Cassisi, Tiziana Morselli, Concetta Massaro, Lella Oresti. Maria Concetta Goldini, Lina Orlando, Anna Maganuco, Franco Città, Cinzia Siragusa.
Sez. C: Presidente Elias D’Aleo e delegazione di 3 soci Interact Club di Gela, Ninfa Cassarino, Filippa Ciaramella, Donatella Di Nisi, Sara D’Amaro, Tiziana Dicembrino, Roberta Incardona. La partecipazione è riservata a tutti i testi pubblicati dal 1 gennaio 2024 al 15 marzo 2025 Salvo per la terza sezione che va a vige il solo vincolo di termine pubblicazione entro il 31 marzo 2025, sia in formato cartaceo o e-book con ISBN.
La cerimonia finale si svolgerà presso la splendida location del club Nautico, per quale si ringrazia in uno il Presidente Avv. Giacomo Iozza per la disponibilità mostrata a suggello di una storica collaborazione con il Rotary club Gela, e sarà venerdì 20 giugno 2025 alle ore 19:30. La pubblicazione del bando ,oltre a essere presente nei canali istituzionali e social del Rotary club Gela sarà presente anche presso le più note piattaforme di premi nazionali letterari.
Il Premio è articolato in tre sezioni_- sez. A: “Alfonso Parisi” narrativa – volumi pubblicati fra il 1° Gennaio 2024 ed il 31 Marzo 2025, in formato cartaceo o e-book con ISBN, che non abbiano conseguito alcun premio letterario alla data della pubblicazione del bando e non siano stati presentati nell’ambito di manifestazioni del Rotary Club Gela.
– Sez. B: “Federico Hoefer“ poesia – volumi pubblicati fra il 1° Gennaio 2024 ed il 31 Marzo 2025, in formato cartaceo o e-book con ISBN, che non abbiano conseguito alcun premio letterario alla data della pubblicazione del bando e non siano stati presentati nell’ambito di manifestazioni del Rotary Club Gela.- Sez. C: “Fiabe e Favole per Bambini” – volumi pubblicati entro il 31 Marzo 2025, in formato cartaceo o e-book con ISBN, che non abbiano conseguito alcun premio letterario alla data della pubblicazione del bando e non siano stati presentati nell’ambito di manifestazioni del Rotary Club Gela.
Art.2I concorrenti della sez. A dovranno inviare n°3 copie del libro partecipante entro e non oltre il 15/04/2025 a mezzo plico raccomandato (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo postale: Rotary Club Gela – Premio “Terra d’Agavi” – c/o Palazzo Mattina, Corso Vittorio Emanuele 411, 93012 – Gela. All’interno del plico, in busta chiusa, i concorrenti dovranno inviare anche un pen drive usb contenente: il file pdf dell’opera, il file pdf dei propri dati anagrafici indicando nome e cognome, numero di telefono e�mail o altro recapito, autodichiarazione cartacea di partecipazione alla Sez A e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, breve Curriculum letterario.Art.3I concorrenti della sez. B dovranno inviare n°3 copie del libro partecipante entro e non oltre il 15/04/2025 a mezzo plico raccomandato (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo postale: Rotary Club Gela – Premio “Terra d’Agavi” – c/o Palazzo Mattina, Cors Vittorio Emanuele 411, 93012 – Gela. All’interno del plico, in busta chiusa, i concorrenti dovranno inviare anche un pen drive usb contenente il file pdf dell’opera, il file pdf dei propri dati anagrafici indicando nome e cognome, numero di telefono e�mail o altro recapito, autodichiarazione cartacea di partecipazione alla Sez B e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, breve Curriculum letterario.
Art.4I concorrenti della sez. C dovranno inviare n°3 copie del libro partecipante entro e non oltre il 15/04/2025 a mezzo plico raccomandato (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo postale: Rotary Club Gela -Premio “Terra d’Agavi” – c/o Palazzo Mattina, Corso Vittorio Emanuele 411, 93012 – Gela. All’interno del plico, in busta chiusa, i concorrenti dovranno inviare anche un pen drive usb contenente il file pdf dell’opera, il file pdf dei propri dati anagrafici indicando nome e cognome, numero di telefono e-mail o altro recapito, autodichiarazione cartacea di partecipazione alla Sez C e autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, breve Curriculum letterario.Art.5I premi in denaro previsti, consegnati a mezzo di Assegno Circolare, sono:€ 1.000,00 per il vincitore della sez. A€ 1.000,00 per il vincitore della sez. B€ 1.000,00 per il vincitore della s
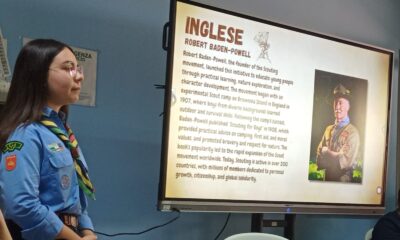
 Attualità8 mesi fa
Attualità8 mesi fa
 Flash news4 mesi fa
Flash news4 mesi fa
 Attualità7 mesi fa
Attualità7 mesi fa
 Flash news4 mesi fa
Flash news4 mesi fa
 Attualità8 mesi fa
Attualità8 mesi fa
 Rubriche8 mesi fa
Rubriche8 mesi fa
 Cronaca7 mesi fa
Cronaca7 mesi fa
 Cronaca12 mesi fa
Cronaca12 mesi fa




















